Futures Practices con un cervello no-Frost. Dal problem solving al problem managing.
- Pierfrancesco Matarazzo
- 18 mag 2020
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 19 nov 2020
Ezio Bosso, eclettico compositore scomparso qualche giorno fa, diceva che “la musica ci insegna la cosa più importante che esista: ascoltare”.
La musica di Bosso sembra non concederci alternativa. Sa scavarci dentro come una talpa testarda, scava finché la sensazione che tenevamo nascosta è alla sua portata. Allora si ferma, la raccoglie e la porta in superficie, dove il nostro cervello cercherà d’impacchettarla, classificandola come disturbo al piano prestabilito. Un problema da risolvere.
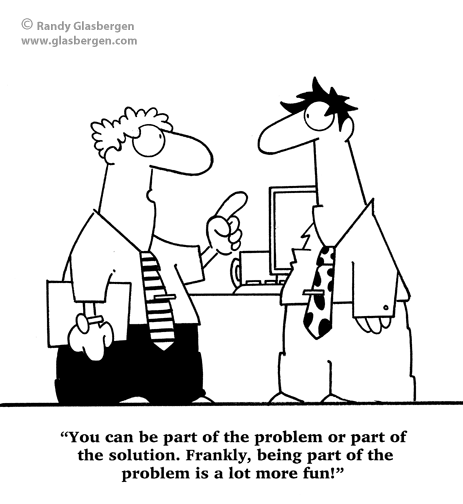
Negli ultimi venticinque anni ho aiutato molte persone a trovare il loro posto nel mondo professionale in cui volevano entrare o crescere, analizzando lo scenario in cui si muovevano, le aspettative dei loro stakeholders (intesi qui nell’idea del filosofo Robert Edward Freeman, ossia gli attori necessari alla sopravvivenza e allo sviluppo sostenibile di un contesto organizzativo o di un ruolo), la griglia comportamentale che utilizzavano e quella che volevano acquisire.
Lavorando insieme a loro per sviluppare nuove consapevolezze e competenze, uno dei primi elementi su cui ci soffermavamo era il famigerato e ostentato problem solving.
La maggioranza delle persone con cui ho lavorato, considerava il problem solving una loro competenza core. Allo stesso modo, le loro realtà organizzative la indicavano come competenza irrinunciabile eppure non ancora sviluppata adeguatamente nelle loro risorse.
Fedele al pensiero di Oscar Wilde (“Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte, a volte, lo sono”) iniziai a domandarmi e a domandare il perché di questo curioso paradosso.
Risolvere problemi. Non facciamo questo dall’inizio della nostra giornata lavorativa fino alla sua conclusione? Se ogni competenza è un muscolo (e nessuno dopo aver parlato con Angela Gallo potrebbe dubitarne) e come tale può essere allenata e sviluppata, com’è possibile che dopo anni di allenamenti esista ancora questa carenza nella percezione delle organizzazioni?
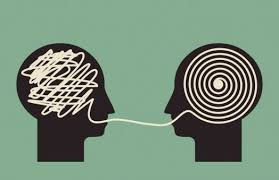
Come spesso accade, si parlano lingue diverse fatte di parole comuni.
Il fisico e startupper Michael Kallet, che ha fatto del problem solving uno dei pilastri dei suoi studi sul pensiero critico, ci ricorda che per risolvere un problema ci sono 3 fasi propedeutiche l’una all’altra:
1. Definire il problema, ossia averne chiari contorni, dinamiche, attori e sua evoluzione prospettica.
2. Identificare la strada più adeguata alla sua risoluzione, mediante analisi dei possibili scenari e relative conseguenze
3. Passare alla decisione, ossia mettere a terra la strategia ideata grazie alle prime due fasi.

Accade però che il problem solver in questione venga spesso valutato (e incentivato) sulla velocità della messa a terra e non sull’ampiezza di pensiero strategico che la dovrebbe determinare, ed è qui che il sistema inizia a scricchiolare. In questo modo il problem solver sarà portato a risolvere il maggior numero di problemi nel minor tempo possibile, comprimendo le prime due fasi di Kallet a discapito dell’efficacia strategica delle sue decisioni, che difficilmente potranno aver preso in considerazione le necessità (attuali e prospettiche) di tutti gli stakeholders.
In più il problem solver si sarà abituato a sentirsi soddisfatto dall’aumento della quantità di task completati in una giornata a discapito del tempo da dedicare al pensiero strategico e prospettico. Questo renderà la sua organizzazione insoddisfatta poiché il problema non sarà stato risolto, ma trasformato in una sua variante (spesso più nociva), che si paleserà nel medio termine, diventando un ‘nuovo’ task per il problem solver.
Questo sistema ciclico di auto-alimentazione di stress (per i problem solver) e aspettative deluse (per le organizzazioni) potrebbe essere sedato da un ansiolitico linguistico, passando dal problem solving al problem managing. Accetteremmo così che molti degli articolati problemi che ci troviamo a gestire non hanno una soluzione immediata e necessitano di una ampia fase di analisi critica e prospettica (libera da tentazione di riciclare a tutti i costi ‘vecchie’ best practices) per trasformarsi in opportunità di crescita sostenibile per manager, professional e organizzazioni. Futures Practices che ci aiutino a gestire i problemi, abituandoci a convivere con alcuni di questi invece di volerli a tutti i costi risolvere, sfruttandone così dinamiche relazionali, radicamenti e debolezze a nostro vantaggio.
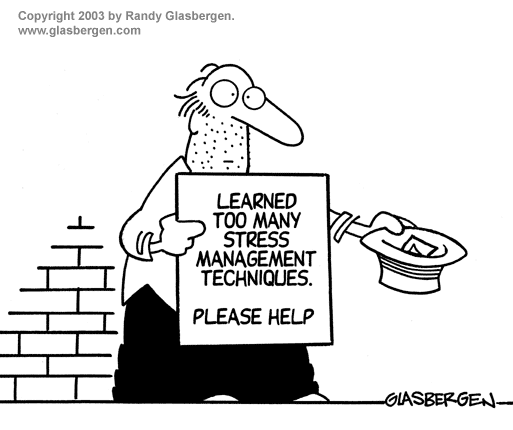
Non è facile? Certo che non lo è, anche per una ragione biochimica. Noi umani abbiamo un cervello no-Frost. Il poeta Robert Lee Frost diceva: “due strade divergevano in un bosco ed io, io presi la meno battuta, e questo ha fatto tutta la differenza”. Ebbene il nostro cervello non è un suo estimatore. Qualsiasi impedimento, qualsiasi cambiamento del percorso neuronale, viene catalogato come possibile pericolo e dispendio non necessario di energia. Ma vi svelo un piccolo segreto, possiamo temerariamente allenarci a scegliere la strada meno battuta. Il primo passo è, come ci ricordava Ezio Bosso, l’ascolto. La prossima volta che vi troverete davanti a un bivio decisionale, prendetevi qualche minuto in più per decidere, ascoltando un parere diverso dal vostro e provate a simulare nella vostra mente l’esito della sua messa a terra. Potreste avere delle sorprese, persino positive!
Buona sperimentazione.






Commenti